Nel 1926, in un convegno a Copenaghen, Einstein disse che “è sbagliato tentare di fondare una teoria fisica esclusivamente su grandezze osservabili. Anzi, in realtà avviene esattamente il contrario: è la teoria che decide cosa possiamo osservare”. Un anno dopo un giovanissimo fisico tedesco, il venticinquenne Werner Heisenberg, fece tesoro di quella frase durante una passeggiata notturna nel Faelledparken (di nuovo Copenaghen), quando gli venne in mente l’idea che sarà per sempre associata al suo nome: l’indeterminazione quantistica.
La sua intuizione fu che, nel caso per esempio di un elettrone in una camera a nebbia, ciò che veniva veramente osservato era una scia di goccioline di acqua fatte condensare. Non era il percorso continuo, ma una serie di punti attraverso i quali l’elettrone era passato; non sapremo però mai quello che fa l’elettrone tra i punti, come non sappiamo quello che fa quando salta tra due livelli energetici nell’atomo. Heisenberg comprese così che la domanda giusta da porsi era che “un elettrone si trova approssimativamente in un punto dato e che si sposta approssimativamente ad una velocità data”. La formula del principio di indeterminazione di Heisenberg stabilisce che il prodotto tra due incertezze, relative alla posizione e all’impulso (massa per velocità), entità che congiuntamente determinano la traiettoria di ogni particella atomica, dev’essere proporzionale alla costante di Planck. “Non possiamo conoscere, per una questione di principio, il presente in tutti i suoi dettagli”, come disse Heisenberg, ma siamo grado di stabilire solo con una certa probabilità dove trovare le traiettorie delle particelle nello spazio e nel tempo. Era la fine del sogno di Laplace, quello di un universo deterministico in cui non esiste incertezza per il moto dei corpi.
Il principio indeterminazione può essere interpretato anche in questi termini: quanto più si vuole determinare con esattezza la velocità di una particella quantistica, tanto più si perderanno informazioni sulla sua posizione. Come nel caso della camera a nebbia, la traiettoria dell’elettrone specifica la sua velocità con una certa precisione anche se la sua posizione potrebbe essere ovunque lungo la traiettoria. Un altro esempio, in un certo senso ideale ma suggestivo ed efficace per rendere l’idea, è quello in cui si volesse stabilire la velocità di un elettrone con un dispositivo di segnalazione autovelox. Nel punto iniziale A, al passaggio dell’elettrone, parte una fotocellula (un fotone) che attiva il timer; quando lo stesso elettrone passa nel punto finale B parte un’altra fotocellula che arresta il timer. Basterà dividere lo spazio percorso dell’elettrone, il tratto AB, per l’intervallo temporale rilevato dal timer ed ottenere così la velocità. Quando però la fotocellula rileva il passaggio dell’elettrone, avviene un urto tra le due particelle, esattamente come tra due palle da biliardo, al punto che la posizione dell’elettrone viene momentaneamente persa. Viceversa, quanto più si vuole fissare la posizione di una particella quantistica tanto più la sua velocità aumenterà a dismisura. In altri termini, quanto più si tenta di confinare una particella subatomica in un piccolo spazio, essa reagisce a questa limitazione agitandosi dentro, e tanto più piccola è la regione in cui è confinata, tanto più velocemente la particella vi si muove. La tendenza delle particelle a reagire con il moto al confinamento implica uno stato fondamentale di agitazione della materia, che è caratteristico del mondo nucleare e subnucleare. Per esempio, negli atomi gli elettroni sono legati al nucleo da forze elettriche che cercano di attrarli, ma essi reagiscono a questo confinamento roteando ad altissima velocità (900 Km al secondo). Son queste alte velocità a far sì che l’atomo appaia come una sfera rigida, simile ad un’elica in rapida rotazione che ci apparirà come un disco. Per tale motivo è molto difficile comprimere ulteriormente gli atomi, ed è ciò che dà alla materia il suo aspetto solido che conosciamo. Le velocità dei protoni e dei neutroni sarà ancora molto maggiore degli elettroni (60.000 km al secondo) visto lo spazio esiguo del nucleo entro il quale sono confinati. Secondo Fritjof Capra, fisico e saggista austriaco, “l’immagine della materia che emerge dallo studio degli atomi mostra che la maggior parte di essa è concentrata in minuscole gocce, separate da enormi distanze in un liquido densissimo che bolle e gorgoglia ferocemente. Nel vasto spazio tra le massicce gocce nucleari in violenta ebollizione, si muovono gli elettroni, che costituiscono solo una piccola frazione della massa totale, ma danno alla materia il suo aspetto solido.”
Sempre nel 1926 un altro fisico austriaco, l’eclettico Erwin Schrodinger, non fece altro che sostituire nell’equazione classica dell’onda armonica le ipotesi di Planck e di de Broglie, per definire così l’equazione ondulatoria che descrive l’evoluzione temporale di una particella nei suoi stati quantici (per esempio le orbite attorno al nucleo nel caso dell’elettrone). La derivazione dell’equazione è una di quelle idee che provoca la tipica reazione “perché non ci ho pensato io?”, anche se era ben lungi dall’essere banale e costituì una vera svolta nella fisica quantistica. In verità, l’onda che scaturiva come soluzione dell’equazione di Schrodinger non era la traiettoria effettivamente percorsa dall’entità quantistica; quello che però si poteva stabilire con estrema precisione era la probabilità di trovare tale entità in un determinato punto dello spazio e in un futuro istante temporale (bastava elevare al quadrato l’ampiezza dell’onda, come scoperto da Max Born nello stesso anno).

La grande pecca dell’equazione d’onda di Schrodinger era che non includeva lo spin, numero quantico che decide la polarizzazione dell’onda di una particella (nel caso degli elettroni stabilisce in pratica il senso di rotazione attorno all’asse). Nel 1927 fu Paul Dirac a trovare l’equazione dell’elettrone, in cui si riuscì per la prima volta a combinare la meccanica quantistica con la relatività di Einstein. La cosa curiosa era che l’equazione sembrava avere due soluzioni, una positiva e una negativa, un po’ come la radice quadrata del numero 4 che dà come soluzioni 2 e -2. In sostanza, l’equazione di Dirac prevedeva l’esistenza sia di elettroni comuni (cioè con carica elettrica negativa) che di elettroni dotati di carica positiva, ipotesi che fu confermata nel 1932 dagli esperimenti di Carl Anderson sui raggi cosmici. L’elettrone con carica positiva fu battezzato positrone o antielettrone. Oggi sappiamo che per ogni tipo di particella esiste una corrispondente antiparticella di carica elettrica opposta (l’antiprotone, l’antineutrone e così via), come insegna la teoria dell’antimateria.
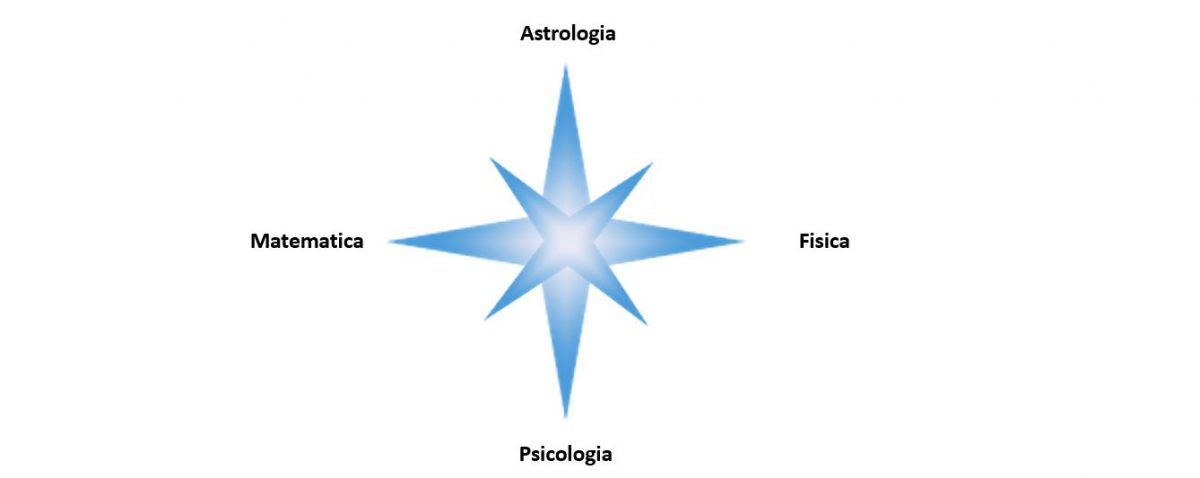
Lascia un commento: